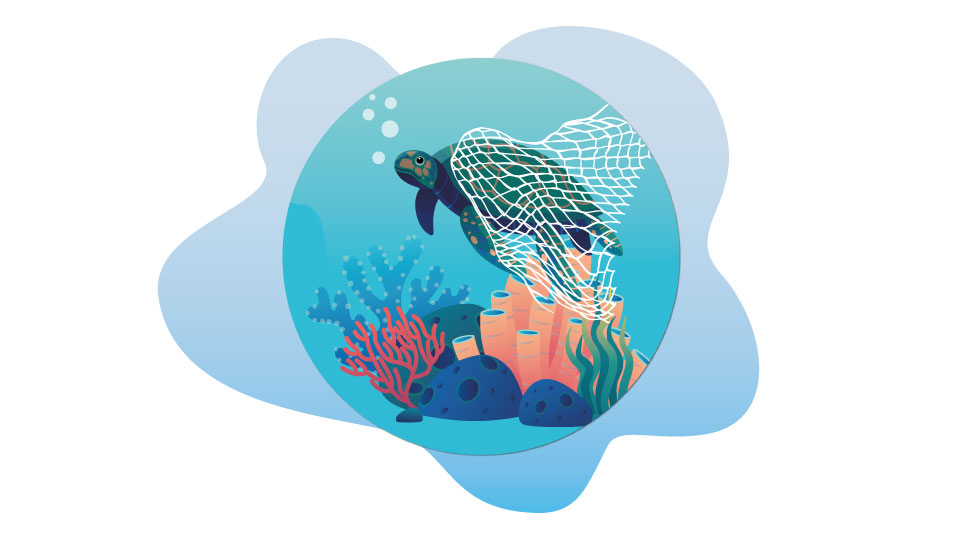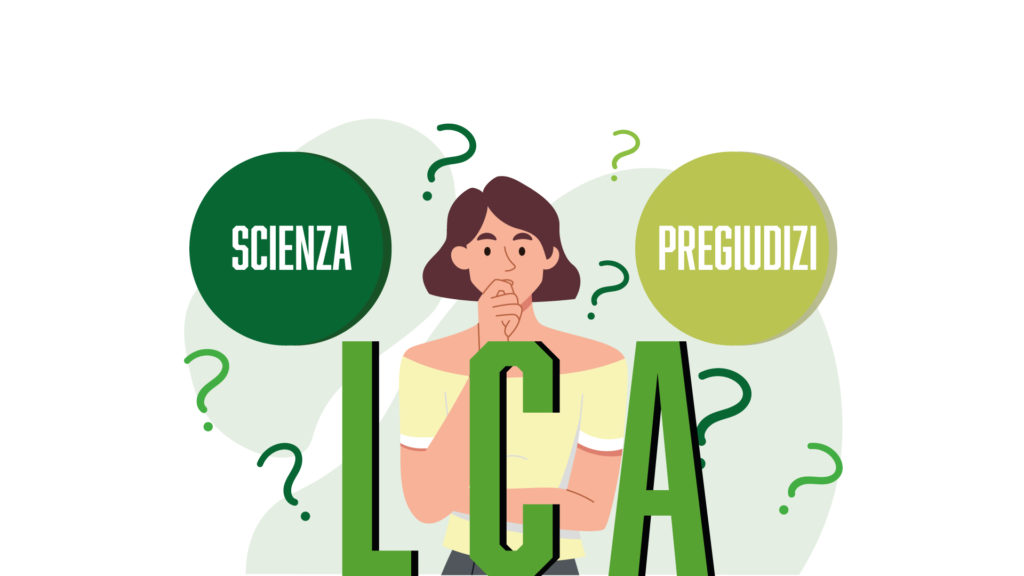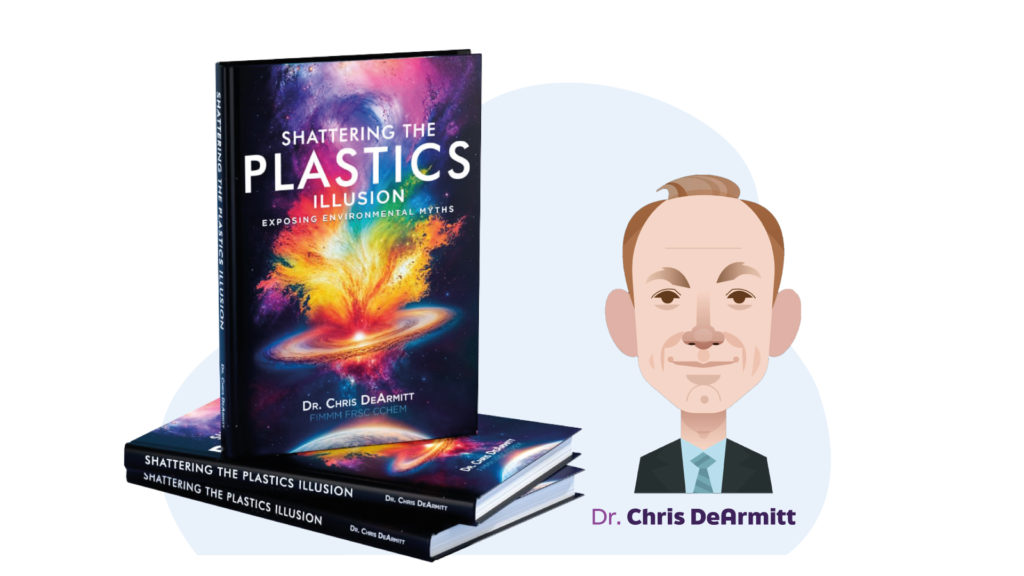Cosa dice la scienza a riguardo e perché dovremmo concentrare gi sforzi per migliorare la gestione della plastica
In questo articolo analizziamo il capitolo relativo alla degradazione della plastica del libro Shattering the Plastics Illusion del Dr. Chris DeArmitt. Come già emerso nei capitoli precedenti, l’autore invita a osservare la questione attraverso la lente della scienza, mettendo in discussione i miti radicati e le generalizzazioni prive di fondamento.
La plastica si degrada: un fatto, non un’opinione
Tra le accuse più diffuse rivolte alla plastica vi è quella di essere un materiale che non si degrada mai, destinato a inquinare per secoli senza mai dissolversi. Questa affermazione è ripetuta frequentemente, ma raramente è accompagnata da fonti verificabili. Secondo DeArmitt, la credenza secondo cui la plastica sia “eterna” deriva da una mancanza di conoscenza dei processi chimici e biologici coinvolti nella degradazione dei polimeri. In realtà, la plastica, come qualunque altro materiale organico, è soggetta a processi di degrado che sono ben documentati nella letteratura scientifica.
Diversi studi dimostrano che le plastiche più comuni, come il polietilene, il polipropilene, il PET, il PVC e il polistirene, si degradano quando esposte a fattori ambientali come la luce UV, il calore, l’ossigeno, l’umidità e l’azione di microrganismi. Il degrado può avvenire attraverso fotodegradazione, ossidazione termica o biodegradazione microbica. La fotodegradazione, ad esempio, comporta la rottura dei legami chimici delle catene polimeriche a causa della luce solare. Questo processo rende il materiale fragile, causando perdita di massa e frammentazione. Successivamente, i frammenti possono essere ulteriormente attaccati da funghi, batteri e altri organismi.
Nel 2014, uno studio pubblicato da Tuasikal sull’International Journal of Polymer Analysis and Characterization ha mostrato che il polietilene a bassa densità (LDPE), se privo di additivi stabilizzanti, perdeva oltre il 70% della sua resistenza meccanica in appena 90 giorni di esposizione in condizioni naturali. Anche nel caso del PET, considerato da alcuni come un materiale “resistente”, le evidenze raccontano una realtà diversa. Stanica-Ezeanu e Matei, in uno studio pubblicato su Scientific Reports nel 2021, hanno osservato che in acqua marina a 35 °C, il PET mostrava una perdita significativa di massa e integrità strutturale in meno di cinque anni. Ancora più sorprendente è il caso del polistirene, spesso citato tra i materiali più persistenti. Ward et al., nel 2019, hanno documentato su Environmental Science & Technology Letters che questo materiale può degradarsi sotto l’esposizione alla luce solare, rilasciando anidride carbonica come prodotto finale, segno evidente di una decomposizione avanzata.
Anche il PVC, che si ritiene particolarmente resistente, è stato oggetto di ricerche che ne dimostrano la suscettibilità alla biodegradazione. Un articolo pubblicato da Peng et al. nel 2020 su Environment International ha mostrato che specifici consorzi microbici e larve di insetti sono in grado di attaccare e degradare il PVC in condizioni ambientali controllate.
La capacità degli organismi viventi di contribuire alla degradazione delle plastiche è ulteriormente confermata da numerosi studi. Yang et al., in una ricerca pubblicata nel 2015 su Environmental Science & Technology, hanno documentato come le larve di Tenebrio molitor riescano a consumare polistirene e polietilene, trasformandoli in CO₂ e biomassa attraverso il proprio sistema digestivo. Anche funghi comuni, come quelli appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium, hanno mostrato la capacità di attaccare e degradare PE, PP e PET, come indicato da Srikanth et al. in uno studio del 2022 pubblicato su Bioresources and Bioprocessing.
La durata della plastica è una caratteristica, non un difetto
L’idea che la plastica non si degradi nasce spesso da un fraintendimento di ciò che accade in natura. Alcuni oggetti possono resistere a lungo se sepolti in ambienti asciutti, privi di luce e poveri di ossigeno, le stesse condizioni che rallentano o inibiscono la degradazione di qualunque materiale organico. Ma in presenza di aria, luce e umidità, i processi di degradazione si attivano, anche nel caso delle plastiche. L’industria, d’altro canto, ha sempre investito nella comprensione di questi meccanismi, poiché la durabilità dei materiali plastici è una caratteristica fondamentale in numerosi ambiti applicativi. Allo stesso modo, quando è necessario favorirne la degradazione, ad esempio per applicazioni temporanee o agricole, vengono sviluppati materiali plastici privi di stabilizzanti, in grado di degradarsi più rapidamente.
Il vero problema non è la plastica, ma la sua gestione
Come sottolinea DeArmitt, la questione centrale non è se la plastica si degradi, bensì se venga smaltita correttamente. L’abbandono nell’ambiente, l’insufficienza dei sistemi di raccolta, la disinformazione e la mancanza di educazione al riciclo sono le vere criticità. La degradazione è un fatto scientifico, documentato e misurabile. Ignorarlo alimenta politiche sbagliate e investimenti poco efficaci, che talvolta producono impatti ambientali peggiori. È quindi essenziale basare ogni decisione su dati concreti e non su percezioni distorte.
Si ringrazia ITP per il prezioso contributo a questa iniziativa e per aver curato l’edizione italiana del libro.
Sito: https://www.itp.company/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itpspa/