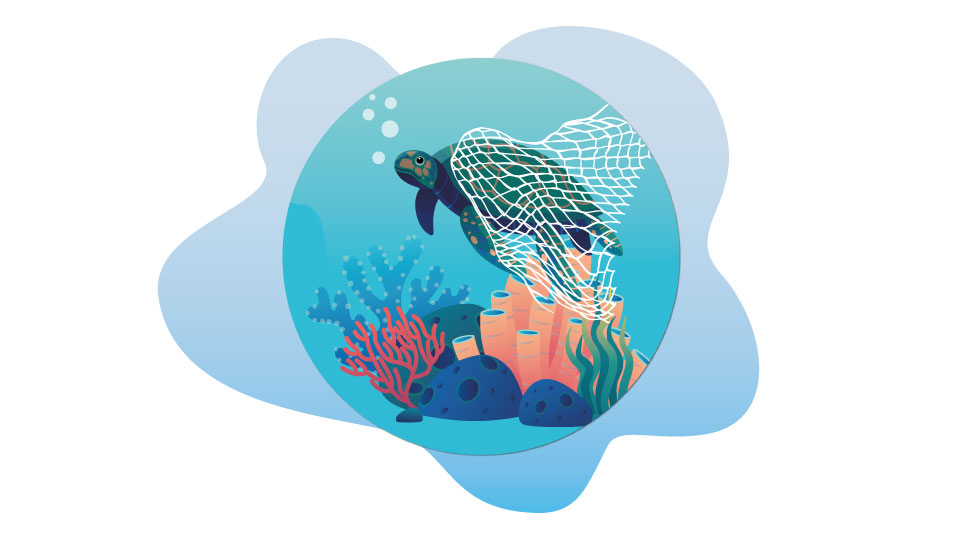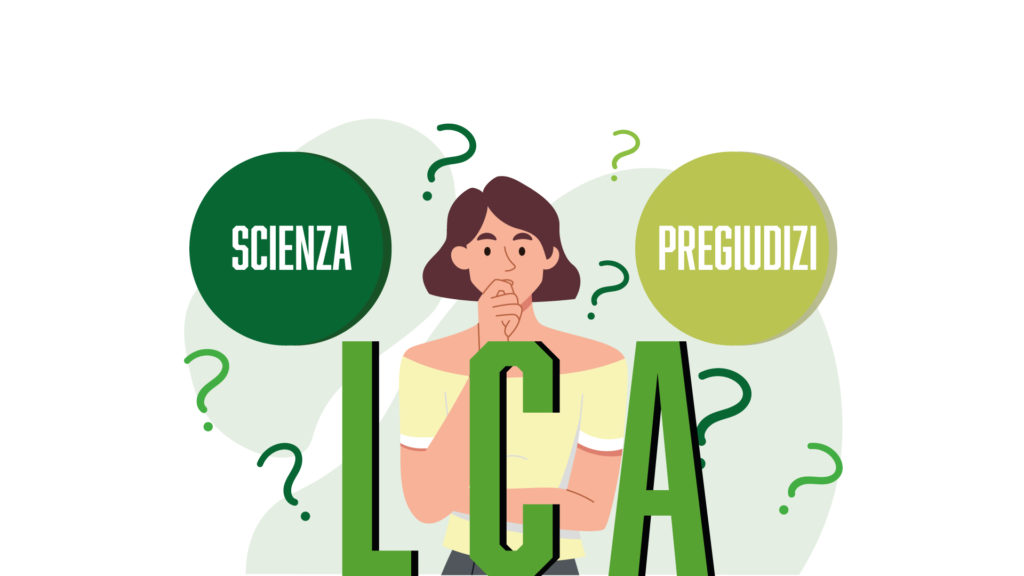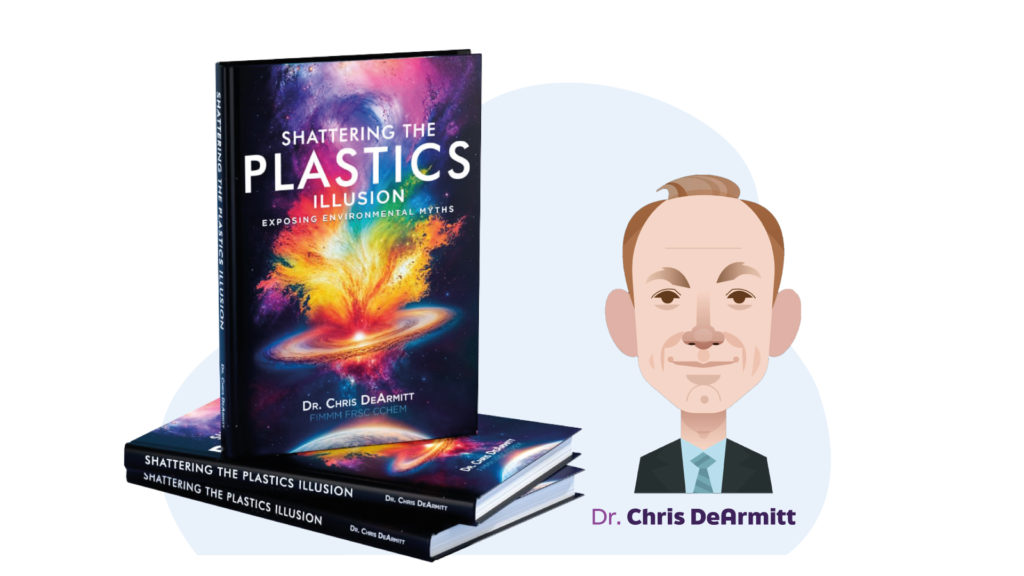Negli ultimi mesi ha destato grande clamore la notizia secondo cui nel cervello umano sarebbero stati trovati fino a 6 grammi di microplastiche, l’equivalente di un cucchiaio di plastica. La ricerca, firmata da Nihart et al., è stata ripresa da testate giornalistiche e programmi televisivi in tutto il mondo. Ma quanto è attendibile questa affermazione?
A rispondere è il Plastic Research Council (PRC), un gruppo indipendente composto da esperti in tossicologia, medicina ambientale, chimica analitica e scienza dei materiali, che ha esaminato oltre 500 studi scientifici peer-reviewed sul tema. Secondo il PRC, i dati riportati nello studio non reggono alla prova dei fatti e sono in netta contraddizione con quanto emerso in decenni di ricerche.
L’idea che le microplastiche rappresentino una minaccia nuova, invisibile e in crescita, è molto diffusa nell’opinione pubblica. Tuttavia, la comunità scientifica ha studiato la questione per oltre cinquant’anni, producendo centinaia di articoli peer-reviewed che ne analizzano ogni aspetto, dai meccanismi di esposizione agli effetti sull’organismo. L’esposizione reale, spiegano gli esperti, è estremamente limitata e non tossica.
Uno studio condotto da Nor et al. mostra che ogni settimana ingeriamo appena 0,0000014 grammi di particelle plastiche. Questo significa che, in tutta una vita, il nostro corpo entra in contatto con non più di 0,005 grammi di microplastiche attraverso l’ingestione. La maggior parte di queste particelle – circa il 99,7%, secondo Powell et al. – viene espulsa naturalmente, senza essere assorbita. La quantità che teoricamente potrebbe rimanere nel corpo umano dopo 70 anni è quindi di soli 0,000015 grammi. Si tratta di una quantità microscopica, che viene comunque neutralizzata dai normali meccanismi di difesa del nostro organismo.
A fronte di questi dati, l’ipotesi di ritrovare 6 grammi di plastica nel cervello umano risulta non solo improbabile, ma fisicamente impossibile. Come sottolinea il PRC, non possiamo accumulare una sostanza in quantità superiori rispetto a quelle a cui siamo stati effettivamente esposti. Eppure, questa semplice evidenza sembra essere stata ignorata dagli autori dello studio.
Le criticità, però, non si fermano ai dati quantitativi. Anche la metodologia utilizzata per identificare la presenza di plastica nel tessuto cerebrale solleva forti dubbi. Gli autori hanno impiegato la tecnica della pirolisi gascromatografia-spettrometria di massa (pyrolysis GC-MS), che prevede il riscaldamento del campione fino alla disgregazione delle molecole, per poi tentare di risalire alla loro composizione originaria. Tuttavia, studi come quello di Rauert et al. dimostrano che questa tecnica non è adatta all’analisi di tessuti biologici, poiché può facilmente confondere la plastica con sostanze naturali come grassi e lipidi, presenti normalmente nel corpo umano. Il rischio di falsi positivi è quindi molto elevato.
Inoltre, nel documento pubblicato non si fornisce alcuna prova diretta che le particelle rilevate fossero effettivamente composte di plastica. Le immagini mostrano frammenti definiti come “putative microplastic particles”, cioè presunte particelle plastiche. Ma senza una conferma inequivocabile della loro natura, queste osservazioni non possono essere considerate evidenza scientifica.
Lo studio è stato già contestato nel 2023 dal ricercatore Chris DeArmitt, e successivamente da altri scienziati, tra cui Jones et al., che ne hanno messo in discussione la validità sia sul piano metodologico che concettuale. Nonostante ciò, la notizia ha continuato a circolare, alimentando timori infondati e contribuendo a una narrazione spesso ideologica sul tema della plastica.
Il PRC conclude ricordando che la Food and Drug Administration (FDA), insieme a numerosi enti regolatori, conferma che l’esposizione a microplastiche è estremamente bassa e non rappresenta un pericolo per la salute umana. L’idea che 6 grammi di plastica possano insinuarsi nel cervello è, a oggi, del tutto priva di basi scientifiche.
Più che contribuire a una corretta sensibilizzazione ambientale, affermazioni infondate come questa rischiano di generare sfiducia nella scienza e di alimentare campagne anti-plastica che, paradossalmente, possono avere effetti negativi sull’ambiente. La sostituzione indiscriminata della plastica, infatti, spesso comporta un aumento dei rifiuti, delle emissioni e del consumo di risorse.
Serve quindi maggiore rigore nella comunicazione scientifica, e la capacità di distinguere tra allarme mediatico e dati oggettivi. Solo così si potrà affrontare con lucidità e responsabilità la sfida della sostenibilità.